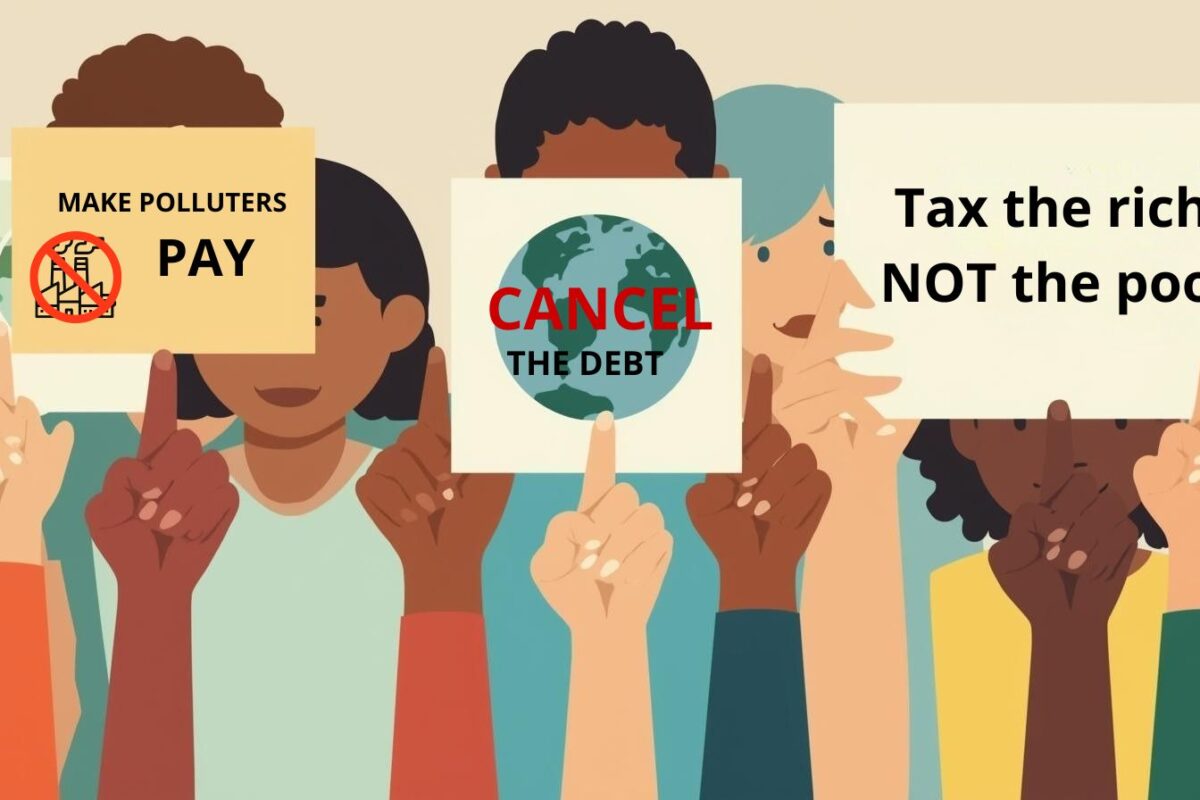Debito ecologico e debito finanziario: due facce della stessa medaglia?
4 Febbraio 2025Massimo Pallottino
Il Giubileo è, per un’antica tradizione del popolo ebraico, il tempo giusto per ripartire. E c’è davvero bisogno di ripartire, in un mondo che sembra aver smarrito speranza e punti di riferimento. L’invito di questo Giubileo è proprio quello di una ‘speranza che non delude’, in ragione della quale siamo chiamati ad adoperarci concretamente per un mondo più giusto.
Il debito estero dei paesi del Sud globale rappresenta oggi un fardello insostenibile, così come lo era sul finire degli anni ’90 del secolo scorso. Molti si ricorderanno della poderosa mobilitazione ecclesiale e civile che in occasione del Grande Giubileo del 2000 scosse le coscienze e anche le istituzioni fino a generare risultati considerati fino a pochi anni prima del tutto impensabili. La legge 209 del 2000 venne approvata all’unanimità del Parlamento, e consentì all’Italia di svolgere un ruolo coraggioso e innovativo nella strategia globale di cancellazione del debito dei paesi più poveri del pianeta. Poveri – lo sappiamo – solo in termini strettamente finanziari, e che dovremmo chiamare piuttosto ‘impoveriti’ da un sistema mondiale che estrae dai loro territori quanto serve per garantire il tenore di vita dei paesi del nord globale. Paesi impoveriti, dunque, e indebitati sul piano finanziario, anche se creditori in termini di risorse naturali: è il ‘debito ecologico’ spesso richiamato da Papa Francesco come uno dei segni più importanti delle contraddizioni che attraversano la famiglia umana.
Negli anni immediatamente successivi al 2000, il debito, eccessivo e ingiusto di molti paesi del Sud globale venne cancellato, consentendo il rilancio di politiche sociali, di investimenti in educazione e in sanità dopo la lunga e buia stagione delle politiche di aggiustamento strutturale proposte dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso. La spinta riformatrice non arrivò però fino alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione delle crisi di sovraindebitamento, nonostante la pressione di una opinione pubblica che aveva colto con chiarezza la necessità di riformare profondamente la governance finanziaria globale. I risultati di quella stagione furono significativi; ma non abbastanza per prevenire, pochi decenni dopo, il rischio della nuova catastrofica crisi che stiamo vivendo oggi.
Quanto avviene oggi non arriva all’improvviso. Era dalla crisi finanziaria del 2007 che la massa di debito dei paesi del sud globale stava aumentando senza sosta, in particolare in America Latina e in Africa, portando così il suo servizio (vale a dire l’incidenza delle quote di restituzione sul capitale e sugli interessi) a livelli sempre meno sostenibili. La pandemia, con il suo impatto di magnitudine moltiplicata proprio nei paesi più poveri, mise in evidenza la fragilità delle catene di approvvigionamento globale, e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, causò un ulteriore shock globale.
Questi fattori hanno innescato dinamiche complesse: l’inflazione che ha colpito materie prime e beni industriali ha aggravato le prospettive economiche globali, con effetti diffusi su tutto il pianeta, ma particolarmente gravi nei Paesi più vulnerabili. Le tensioni inflazionistiche hanno accelerato la spirale del debito, rendendo il rifinanziamento dei crediti in scadenza sempre più oneroso e difficile. Nei paesi a basso reddito, il servizio del debito è salito nel 2023 a oltre 62 miliardi di dollari, con un aumento di oltre un terzo rispetto al 2021, raggiungendo così il 3% dell’Reddito Nazionale Lordo.
Quasi il 60% dei Paesi che rientrano nel ‘Debt Sustainability Framework (DSF)’ si trovano ora in situazione di sofferenza debitoria o sono ad alto rischio di entrarvi. Questo vuole dire una erosione costante e gravissima del loro ‘spazio fiscale’ vale a dire della capacità dei governi di costruire un quadro di politiche pubbliche in grado di fare fronte alle sfide di questo tempo: sono a rischio le politiche sociali necessarie per dare una risposta a società sempre più diseguali; ma anche i necessari investimenti di adattamento al cambiamento climatico che lasciano proprio i più poveri nella situazione di maggiore vulnerabilità. Non si tratta di problemi distanti dalla nostra vita quotidiana. La crisi dell’approvvigionamento delle materie prime è un fenomeno che tocca pericolosamente anche i paesi del nord globale; senza contare l’ovvia accelerazione dei fenomeni di mobilità umana dai paesi in cui le condizioni di vita peggiorano in ragione di questi fenomeni complessi. Questo insostenibile fardello nasconde quindi una questione di giustizia: ancora una volta il debito è dunque in buona parte il frutto di dinamiche finanziarie mosse da meccanismi e interessi globali che ben poco hanno a che vedere con le necessità di base dei popoli del mondo.
Il panorama attuale è però molto diverso da quello di 25 anni fa: la maggior parte del debito dei paesi più poveri è ormai in mano a creditori privati, oppure a paesi come la Cina, che si trovano al di fuori del perimetro dei creditori ‘tradizionali’ che qualche decennio fa avevano il potere e l’onere di dettare regole e condizioni. Ora, dunque, il panorama è assai più complesso e frammentato, ed è dunque più importante la necessità di ‘fare ordine’ : la priorità è quella di allargare lo ‘spazio fiscale’ dei paesi del sud globale, cioè evitare che rimangano strangolati in una morsa di creditori che non mollano la presa, senza avere la possibilità di fornire servizi minimi ai propri cittadini, e di portare avanti quelle misure di adattamento climatico imposte da una situazione globale che certo non hanno causato loro. Occorre però oggi lavorare non solo per alleggerire il peso ormai insostenibile del debito, ma per fare sì che questo coinvolga anche i creditori ‘non tradizionali’: il rischio, in caso contrario è quello che (come avviene già adesso in buona misura!) le risorse messe a disposizione dei creditori pubblici (nuovi prestiti, rifinanziamenti, o ristrutturazioni/cancellazioni) siano in realtà usati proprio per restituire fino all’ultimo centesimo quanto dovuto ai creditori privati! Ma occorre anche costruire un quadro, realmente multilaterale e democratico, in grado di prevenire e se necessario gestire le crisi di sovraindebitamento. Qui il rischio è che si riesca a dare una risposta almeno parziale alla crisi di oggi (e già da questo siamo ancora purtroppo abbastanza lontani!); ma che tra pochi anni ci ritroviamo al punto di partenza, con una nuova crisi, e senza un sistema di governance globale in grado di offrire delle soluzioni. In poche parole, esattamente come ci troviamo oggi… L’occasione del prossimo vertice ‘Finanza per lo Sviluppo’, convocato a Siviglia per il 30 giugno 2025, dovrà essere sfruttato proprio per costruire un approccio diverso e più efficace.
Si tratta di una sfida ineludibile e urgente ancora di più in questo momento: la fragilità del sistema finanziario internazionale si unisce infatti ad una visibile accelerazione degli effetti della crisi climatica, come testimoniano i rapporti dell’IPCC. Sempre più è chiaro che politiche sociali e politiche climatiche sono due elementi inscindibili.
Il debito rappresenta dunque un ‘doppio cappio’ al collo della famiglia umana, che si stringe per il combinato disposto della disfunzionalità del sistema finanziario globale e di eventi straordinari (ma né imprevedibili né imprevisti…) come la pandemia e i conflitti che attraversano il pianeta: da una parte esso rallenta la lotta e il contrasto al cambiamento climatico, e dall’altra impedisce le risposte necessarie ad evitare che i costi di quest’ultimo vengano pagati in prevalenza proprio dalle fasce più fragili della popolazione del pianeta. Ma se nel 2000 era facile pensare al debito dei paesi impoveriti come ad una questione di ingiustizia, ma che in qualche modo metteva in campo i suoi effetti ben lontano dai nostri confini, oggi non è più così: le faglie della disuguaglianze attraversano la nostra società come attraversano l’intera famiglia umana; i vincoli di bilancio e le spese militari soffocano il nostro welfare e il nostro sistema sanitario come il debito soffoca i popoli più fragili del pianeta; i poveri sono i primi a finire nella trappola del debito, a livello globale come anche nei nostri territori; gli effetti del cambiamento climatico ignorano i confini e le volontà dei governi senza che si riescano a mettere in campo risposte realmente efficaci, mentre masse di migranti, sfollati e rifugiati ci pongono di fronte alla dura realtà di un mondo in grave crisi.
La speranza non delude. Essa non è cieco ottimismo, ma chiama tutti a riconoscere i segni dei tempi, e a farne motore di consapevolezza e azione. Il Giubileo è l’occasione per ricominciare a farlo, in modo efficace, insieme.
Tratto da Mosaico di Pace – Gennaio 2025 | Image by freepik